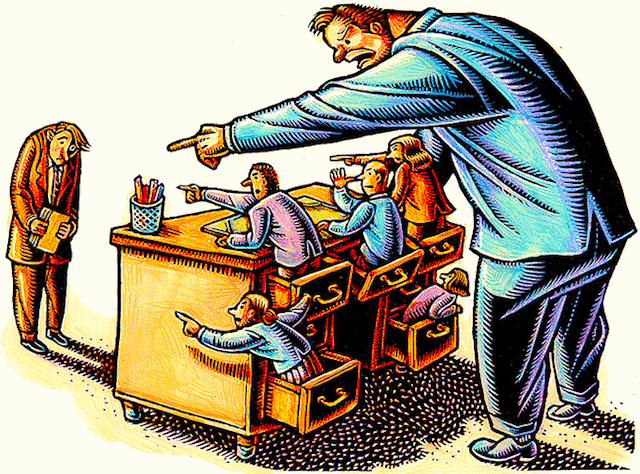Responsabilità datore in caso di mobbing:
La circostanza che la condotta di mobbing sia stata compiuta da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro su cui incombono gli obblighi di cui all’art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo e nella specie la durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro che l’ha comunque tollerata.
È quanto ritenuto dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015 (Presidente: Stile, Relatore: Napoletano) con la quale si afferma il principio secondo il quale viene ritenuto responsabile il datore di lavoro per i danni conseguenti da fatto illecito commesso dai suoi dipendenti, come una forma di responsabilità per colpa dovuta al fatto di non aver adottato misure atte ad eliminare i comportamenti vessatori a danno di un altro lavoratore.
La Corte Suprema, poi, pone in rilievo anche l’aspetto della durata nel tempo del comportamento vessatorio, sempre per sottolineare la responsabilità datoriale, poiché ritiene che “la durata le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro che l’ha comunque tollerata”. È anche per questo, quindi, che la Corte Suprema ha ritenuto responsabile il datore di lavoro proprio per la sua inerzia di fronte alle reiterate condotte ostili nei confronti del dipendente ed ha confermato quindi, con la sentenza n. 10037/2015, la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni come stabilito dalla Corte di Appello.
In particolare il caso all’esame della Corte Suprema riguardava il caso di una dipendente di un ente comunale che aveva subito la sottrazione delle mansioni, l’emarginazione, lo spostamento senza plausibili ragioni da un ufficio all’altro, l’umiliazione di essere subordinata a quello che prima era un suo sottoposto, l’assegnazione ad un ufficio aperto al pubblico senza la possibilità di poter lavorare; tale situazione professionale unita alle continue umiliazioni e vessazioni le avevano provocato un danno psicologico (psicosi paranoide) di cui non aveva mai sofferto prima.
La Cassazione, considerando la sentenza di appello giuridicamente corretta e formalmente coerente, rigettava il ricorso proposto dal datore di lavoro.